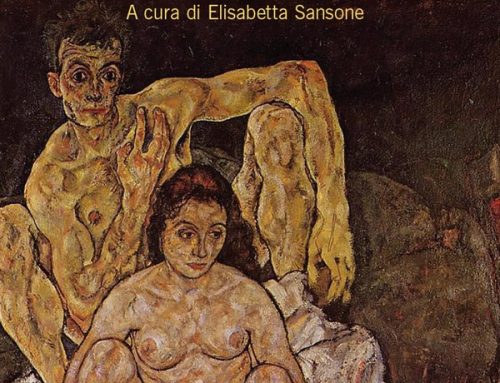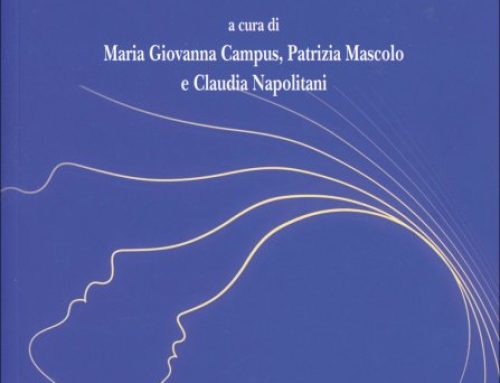In questa pagina sono raccolti i testi che abbiamo ricevuto a seguito della morte di Diego Napolitani, avvenuta il 9 luglio 2013. Per altri contributi si rimanda a https://www.journal-psychoanalysis.eu/diego-napolitani-1927-2013/ e al n. 1/2014 di Antropoanalisi
DIEGO
Occhi liquidi di cielo e di mare confusi all’orizzonte mentre il sole annega nel tramonto ti guardo andar via contro il sole stagliato mi hai dato la gioia di capire la vita attraverso il sorriso del tuo cuore mi hai lasciato il silenzioso fragore delle parole.
(12 luglio 2013) (tratta da “Impareggiabile rumore il silenzio” di Maria Pina Santoro, pag.86, Falvision Editore, novembre 2013)
Paolo Tucci Sorrentino (settembre 2013)
La morte di Diego Napoliani è avvenuta il 9 luglio di quest’anno, più di due mesi sono trascorsi, eppure ancora non mi è facile proporre pubblicamente un ricordo. Non mi è facile sceverare ciò che interessa soltanto me, la mia sfera privata, da ciò che interessa voi che mi leggete. La morte dell’altro ci coglie sempre impreparati, anche se ci si limita al ricordo del nostro affetto per chi non c’è più. Prenderò spunto a partire da una domanda che, sere fa, ci animò nel dopocena casalingo con amici e colleghi, tutti appartenenti alla SGAI, l’associazione fondata da Diego e di cui è stato sempre l’indiscusso leader. Una di quelle domande che non sarebbero mai proposte in circostanze ufficiali perché, di per sé, era insensata; talvolta, però, è proprio a partire da una apparente impertinenza che può prendere corpo una questione interessante. Un collega, riferendosi alle numerose citazioni che Diego, nel corso della sua vita, ha fatto sia di Nietzsche che di Heidegger, chiedeva: «Vattimo sostiene che l’opera di Heidegger è la continuazione dell’opera di Nietzsche – e in accordo con essa. Io la penso diversamente, a me sembrano personaggi divisi da un’idea diversa della storia come della vita. Ebbene, tra i due a chi assimilereste maggiormente Diego Napolitani?». Proverò a proporvi un mio ricordo proprio a partire da un punto che unisce e divide i tre personaggi in questione; ma, in questa circostanza, non ne vedrò tanto il risvolto scientifico, quanto il versante più personale. Mi rifaccio dunque all’esergo che Heidegger pone in cima al suo Nietzsche, opera composta dalle lezioni e da altre ricerche e conferenze successive alla pubblicazione di Sein und Zeit. La citazione è tratta da La gaia scienza: “la vita … più misteriosa – da quel giorno in cui inaspettato venne a me il grande liberatore, quel pensiero cioè che la vita potrebbe essere un esperimento di chi è volto alla conoscenza.” A partire da questa citazione si potrebbe porre un’altra domanda. Nel tracciare questo esergo a chi si riferiva Heidegger? Ad un suo progetto o a quanto auspicato in vita da Nietzsche? E, in ogni caso, come intendere il termine “vita”? Limitarla alle avventure di carattere filosofico o estenderla alle frequentazioni, agli amori, insomma a tutta l’esistenza? E possiamo, audacemente, porci questo stesso interrogativo per ricordare Diego? Ebbene, senza negare che Heidegger abbia sempre cercato di condurre una vita da filosofo, tuttavia dobbiamo ricordare i suoi legami non sempre chiari con il mondo cattolico, la prudenza che ha contraddistinto la sua unione matrimoniale, la segretezza della sua relazione con Hannah Arendt, la sua adesione al nazionalsocialismo, e così via. Al confronto sembra proprio che, invece, Nietzsche, nel parlare di “vita”, la intendesse tutta intera e con minori riserve, la vivesse con più spregiudicatezza e con una passione più libera. Ed infatti cosa è l’aforisma 324 della Gaia Scienza da cui è tratto l’esergo? Una riflessione filosofica, una confessione come si fosse prossimi alla morte, una confidenza ad un amico? Dirò allora che un aspetto che ha contraddistinto la vita e la professione di Diego Napolitani è stato proprio l’assenza di una netta separazione tra i due campi, tra la vita concreta e la vita filosofica. Con ciò non nego che ci siano differenze tra i modi di Nietzsche e di Diego, ma, così come Nietzsche scrisse che bisogna servire la storia, così, potremmo aggiungere, Diego ha voluto sempre servire la vita. Cioè, ha voluto fare in modo di viverla pienamente ed autenticamente, non già rifacendosi a ciò che si dice debba essere o alle convenzioni che per lo più ci guidano nel viverla, ma scavando in ciò che poteva trovare compimento nelle sue scelte; un umanesimo decostruito con ferma ostinazione. «Non posso parlare di libertà con i miei pazienti se non sono io stesso ad andare alla sua ricerca», mi disse una volta. E così, citando prima Neruda e poi Claudio Magris, ricordava che se è vero, come canta il poeta, che è per nascere – ovvero: rinascere – che siamo nati, è altrettanto vero, come scrive il saggista triestino, che “nascere è più terribile, più violento e più assurdo che morire”. e, ben consapevole di quanto sia difficile rinascere, sapeva essere molto vicino a quanti mostravano di voler rinascere a nuova vita. «E chi saprebbe ridere e vivere bene, senza intendersi prima di guerra e di vittoria?» Così si chiude l’aforisma di Nietzsche il quale, aiutandomi a superare le mie difficoltà a raccontarvi di Diego, mi fa ricordare come egli abbia vissuto la sua vita come un impegno da “vivere gioiosamente” o una battaglia di cui “gioiosamente ridere”. I suoi occhi azzurri, sin dal nostro primo incontro in una luminosa giornata settembrina di 36 anni fa, mi sono sempre apparsi carichi di passato e instancabilmente rivolti al futuro. Ogni tanto traspariva una sua impazienza, quasi volesse abbreviare il tempo dell’attesa, come un tenero invito a se stesso e ai suoi interlocutori ad avere fiducia. «La vita non mi ha disilluso.» Questo l’esordio che dà all’aforisma un’aria da congedo, e questo è lo stato d’animo che caratterizzò gli ultimi mesi della vita di Diego. Alla fine di una vita vissuta con una certa impazienza – com’era bello vedere la certezza che sorreggeva la sua inquietudine! – appariva, nell’approssimarsi della fine, via via più sereno, come chi non si senta disilluso da ciò che la vita gli ha concesso. Le sue lezioni e gli incontri con i colleghi che andavano a parlargli acquistavano via via una intensità e una intimità particolari, come se fosse possibile cogliere, tra le pieghe dell’amicizia, l’ignoto. Gli ultimi giorni sono stati carichi di dolore e sofferenza, sua e di coloro che lo accudivano, in particolare della moglie Carlotta e dei figli più grandi, Claudia Fabio e Martino. In quei momenti facevo fatica a pensare, ma ora ho l’impressione che proprio nel momento del congedo egli abbia voluto lasciare un sentimento di pace. La pace, io credo, non si conquista, ma si riceve in dono, e io non posso che essergliene grato. Federico Leoni (settembre 2013) La prima cosa è la voce. La prima cosa che mi ritorna in mente. Calda, profondissima. A volte invece incerta, scossa dalla tosse, quasi metallica, un filo d’acciaio. Quella tosse acquosa che lo ha squassato per anni, e da ultimo ha annunciato il male che l’ha travolto. Una voce giovane e vecchia, felice e cavernosa, piena di desiderio e venata di distruzione. Napolitani era come la sua voce, a cui ha affidato per decenni la sua pratica di analista, le tante lezioni e conferenze, gli scambi con gli amici, gli affetti della sua tribù numerosissima. Una voce di molte voci, splendide e contrastanti, segnate anche da dissonanze violente. Una voce che invitava a correre in avanti, a guardare più lontano. A volte la voce di un veggente divorato da questo desiderio feroce di andare oltre i consueti ritornelli, di avanzare senza rete, insofferente di ogni sponda, di ogni precedente. Il primo analista di Diego Napolitani pare gli avesse detto, a conclusione di una seduta di tarocchi, cosa non inusuale da parte di quello strano personaggio: “Diego, tu sei proprio un figlio di puttana.” Era Ernst Bernhard a pronunciare questa diagnosi inconsueta, il primo traghettatore di Jung in Italia, fautore di uno junghismo opaco e composito, geniale e farraginoso. Un personaggio quasi mitico, emigrato dalla Germania durante il nazismo, approdato in Italia e subito confinato dal Regime su un’isola lontana, tornato a Roma alla fine della guerra, dove avrebbe esercitato come analista fino alla morte, alla metà degli anni Sessanta. Federico Fellini e Giorgio Manganelli erano stati suoi pazienti a lungo. Solo la punta di un iceberg dalle infinite diramazioni. Una figura misteriosa e influentissima, la sua. Tempi lontani da quello “junghismo critico” che anni più tardi si sarebbe imposto per iniziativa di Mario Trevi, che di Napolitani rimase poi amico fraterno per una vita. È un mondo che si ritrova bene tra le pagine di Bernhard, in quel testo quasi iniziatico che è la Mitobiografia, ovviamente pubblicato da Adelphi. Del resto, sempre Manganelli diceva che la psicoanalisi è una branca della letteratura, al pari della teologia. E non giurerei che un’idea del genere sia rimasta senza esito, nella mente del giovane Napolitani, fino a certe sue requisitorie di anziano analista contro la psicoanalisi tutta, anche o soprattutto freudiana. Napolitani veniva da Napoli, rampollo di una famiglia di avvocati. Una famiglia abbiente e, a suo dire, vessata da un padre difficile e gravata da una madre bella, avara, lamentosa. Il fratello di Diego, Fabrizio, andò a Roma a studiare psichiatria dopo la laurea in medicina. Diego fece lo stesso poco dopo. Arrivò a Roma e avviò l’analisi con Bernhard. Bernhard parlava un buon italiano, Napolitani parlava un ottimo tedesco. Credo che nell’analisi alternassero le due lingue. Un terzo fratello, Corrado, divenne a sua volta avvocato. La tata tedesca ero uno status symbol nella Napoli bene di quegli anni. E per almeno due dei tre figli dell’avvocato si rivelò una chiave capace di aprire molte porte. Fabrizio se ne andò dall’Italia, specializzatosi in psichiatria, per approdare a Kreuzlingen, Svizzera, dove fu collaboratore di Ludwig Binswanger. Si appassionò alla psicoanalisi, conobbe la fenomenologia, poi si avvicinò al lavoro sui gruppi di matrice anglosassone, studiò e lavorò in Inghilterra, fu tra i primissimi protagonisti della nascita della gruppoanalisi italiana, sposò infine la versione foulkesiana dell’ampio e sfrangiato modello gruppo-analitico. L’altro protagonista sarebbe stato il fratello Diego. Il quale si laureò a sua volta in medicina, poi si specializzò in endocrinologia, e solo da ultimo in “Clinica delle malattie mentali e nervose”, come allora si chiamava la psichiatria. Si direbbe che lo attirasse, nell’uomo, la macchina. Sempre più fine, sempre più impalpabile, disciplina dopo disciplina, specialità dopo specialità. Ma pur sempre macchina. Da Roma arrivò a Milano a metà degli anni Cinquanta. Lavorò come psichiatra. Fece una seconda analisi. O una prima analisi, se si guarda la cosa dal punto di vista dell’istituzione a cui stava approdando. Alla SPI gli assegnarono come analista Franco Fornari. Singolare procedura, questa dell’assegnazione dell’analista. Napolitani conservava di Fornari un’opinione alta e polemicissima. Verosimilmente avrebbe osservato che neppure con questa seconda analisi si poteva star sicuri di aver fatto un’analisi vera e propria. E che forse un’analisi vera e propria, un’esperienza non banalmente medicalizzante, un percorso non semplicemente ortopedico, in quegli anni e in quegli ambienti era di fatto impossibile. Salvo forse con Musatti, suo supervisore, di cui diceva molto bene ma molto poco, o poco volentieri. Maestri, insomma, non ne aveva avuti. O ne aveva avuti, ma diversissimi e difettosissimi, almeno nel suo racconto. Le chiacchierate di Napolitani lasciavano intendere molte paternità e nessuna, per la sua pratica di analista e forse per il suo modo di stare al mondo. Bernhard, nel suo modo bizzarro, era tutt’altro che uno sprovveduto. Napolitani finì l’analisi con Fornari, e divenne membro della SPI. Freudiano ortodosso, mi disse una volta con qualche ironia. Aveva fatto un passo ulteriore, era un tecnico di macchinari ancora più fini. Ma ancora sempre macchinari. Così, almeno, Napolitani intendeva il kleinismo di Fornari e dei freudiani di quegli anni. La sua polemica contro la psicoanalisi nasce da questa convinzione, da questa insofferenza per un medicalismo e un meccanicismo che Freud, a suo dire, non avrebbe mai abbandonato. Di fatto, per la cronaca, neppure Napolitani abbandonò mai la Gradiva, il bel bassorilievo di gesso bianco che ancora teneva in casa, in posizione non così defilata, anzi intimissima. Un simbolo iniziatico, che ogni giovane analista freudiano riceveva dalla SPI, una volta accolto tra le fila dell’istituzione. Intanto Napolitani fondava, a Milano, poco dopo che Fabrizio aveva fatto lo stesso a Roma, le primissime Comunità Terapeutiche italiane, avendo in mente Maxwell Jones, tenendo conto di Wilfred Bion, che durante la guerra aveva elaborato i primi modelli gruppoanalitici lavorando coi militari britannici traumatizzati dalle missioni belliche, e guardando con attenzione all’esperienza di Thomas Maine al Cassel Hospital di Londra.La SPI milanese lo ammonì. L’iniziativa della psicoanalisi in gruppi e dell’istituzione psichiatrica psicoanaliticamente fondata, benché non esclusa, non rientrava allora nelle linee guida del freudismo ufficiale. Napolitani abbozzò, e rientrò nei ranghi. Poi tornò alla carica coi suoi progetti, e venne richiamato ancora. I rapporti tra lui e la SPI si raffreddarono, ma la rottura arrivò molto più tardi, a metà anni Novanta, con uno strappo di cui si avvertivano ancora, qualche decennio più tardi, l’affetto duplice, il bruciore incandescente e il diniego incendiario di quel bruciore. Negli anni Settanta fondò la Società Italiana di Gruppoanalisi, che nel tempo ha aperto sedi a Roma, con la guida del fratello Fabrizio, a Torino, recentemente a Palermo, con la guida della figlia Claudia. In quella stessa stagione anche altri lavoravano in direzioni simili. Nasceva la sociogruppoanalisi, per esempio. Luigi Pagliarani, che Napolitani aveva conosciuto tra una seduta e l’altra nello studio di Fornari, rimase sempre suo amico. Orientato piuttosto al mondo delle aziende e alle applicazioni della psicoanalisi, ma complice di molte avventure. Un amico, e forse un doppio. La storia di Napolitani è piena di questi doppi, compagni di strada che diventano ora fonte di ispirazione, ora seguaci della sua sempre più creativa riflessione sulla clinica come sulla teoria, ora avversari degni di insulti che per chi li scagliava equivalevano a vere e proprie fucilazioni. Bastava poco, e la regressione teorica era sanzionata con violenza: “freudiani”, “veterokleiniani”, “idraulici delle passioni umane”. Non ultimo, il più buffo e autobiografico degli insulti: “endocrinologi”. Insomma il punto, per lui, era rifare Freud senza la macchina freudiana. Rifare la psicoanalisi senza propaggini medicaliste, e per altro verso, ma era in fondo lo stesso verso, senza tentazioni ortopediche, come dicevo, cioè moralizzatrici, edificanti o edificatrici. Che è poi quello che tutti gli analisti dotati di sensibilità teorica e di qualche sentore della propria collocazione storico-politica hanno cercato di fare, magari in modi diversissimi, dopo Freud e soprattutto dopo i postfreudiani, dopo la Ego-psychology e dopo l’americanizzazione di quella che doveva essere peste, ed era diventata un’aspirina per famiglie bene e per funzionari performanti dell’adorniana amministrazione totale. Anni settanta. Dopo aver letto e attraversato Jung, Freud, poi Klein e Winnicott, poi Bion e Foulkes, Napolitani leggeva Nietzsche e Heidegger. Per capire gli ultimi vent’anni o trent’anni del suo lavoro, cioèla sua stagione più matura e personale, si deve forse partire da qui. Da questi due filosofi, e dalle frequentazioni coi filosofi italiani che lavoravano in quella direzione. Gianni Vattimo, amatissimo. Carlo Sini, frequentato per una stagione più breve e forse superficiale. Umberto Galimberti, vicino e lontano ad un tempo, molto prossimo per un certo tratto di strada, poi allontanatosi o allontanato improvvisamente. Napolitani è freudiano che ha attraversato Heidegger e Nietzsche, se dovessimo racchiuderlo, e sarebbe quasi un insulto ai suoi occhi, in una definizione. È un freudiano che ha ripensato la psicoanalisi, la nevrosi, la divisione cui soggiace il soggetto umano, il cammino “emancipativo” della psicoanalisi, nella doppia luce di Nietzsche e Heidegger. Non erano in molti, in quegli anni, a intuire la necessità di un’operazione di quel genere. E se Heidegger aveva avuto un illustre interprete in psicoanalisi, cioè Lacan, odiatissimo quest’ultimo da Napolitani ma vicinissimo a lui in una quantità di formulazioni e di piccole e grandi manovre cliniche, Nietzsche era rimasto invece senza scuola, dalle parti degli analisti. Con qualche parziale eccezione, che guardacaso coincidevano coi due soli analisti italiani che Napolitani citasse con ammirazione: Elvio Fachinelli ultimamente, e in una fase più lontana Francesco Corrao. Non è facile dire in breve che cosa significasse, per Napolitani, ripensare la psicoanalisi dopo Heidegger e dopo Nietzsche. Heidegger per Napolitani significava La questione della tecnica e Che cosa significa pensare, anche se in tempi recenti Heidegger era tornato a essere soprattutto l’autore di Essere e tempo. Ma La questione della tecnica e Che cosa significa pensare erano i testi che citava più spesso e che conosceva a memoria, e il suo heideggerismo era tutt’uno con la polemica contro la tecnicizzazione dei saperi e l’oblio del pensiero, per dire brevemente. Il che, riportato alla psicoanalisi, poteva voler dire la medicalizzazione dell’uomo e l’ascrizione della psicoanalisi al novero delle scienze e degli strumenti tecnocratici, dei mezzi con cui addomesticare sistematicamente anche l’ultima riserva dell’ultima risorsa industriale, come Heidegger profetizzava, la “risorsa umana”. Il suo amico Pagliarani temo ricadesse, ai suoi occhi, in questo girone infernale. Credo possa essere riletto su questo sfondo anche l’interesse successivo che Napolitani nutrì per le teorie della complessità, per una psicoanalisi che non voglia farsi scienza ma arte dialogica, per la sempre rinviata e sempre accarezzata costruzione di un’enciclopedia allargata delle tante pratiche formative dell’umano, le cui tracce riconosceva e apprezzava ultimamente anche negli studi neuro-fenomenologici di cui era lettore avidissimo: Francisco Varela, Vittorio Gallese, prima ancora Antonio Damasio, o Mauro Ceruti e Telmo Pievani. L’uomo, secondo la tesi del nietzscheano Arnold Gehlen, che anche Lacan avrebbe fatto propria pur imprimendole un’altra direzione, è un essere strutturalmente prematuro, testardamente destrutturato, embrionale. Va formandosi sempre, senza sosta, ora conformandosi e alienandosi, ora deformandosi e discostandosi dalle proprie alienazioni e dalle proprie conformità. Il tutto nell’andirivieni di un movimento che Napolitani chiamava dialogico ed ermeneutico, ma che nella sua comprensione non era privo di un elemento che spesso le ermeneutiche e i fautori del dialogo hanno ignorato con conseguenze catastrofiche. Un elemento di lotta e di contesa. Un elemento, di nuovo, fondamentalmente nietzscheano. Altra questione la presenza di Nietzsche nel lavoro di Napolitani: nel suo pensiero e, direi, nella sua pratica di analista. Dovessi azzardare una formula, direi che Napolitani è stato il solo psicoanalista nietzscheano del secolo (a parte Alfred Adler, cacciato da Freud proprio perché troppo apertamente nietzscheano).La sua specificità sta qui, molto più che nelle tante filiazioni attraversate e rigettate, amate e poi odiate, o nei richiami recenti e recentissimi alla fenomenologia binswangeriana e, via Binswanger, husserliana. Tanti motivi, storici, teorici, politici, sociali, dovevano tenere a distanza la psicoanalisi dal nietzscheanesimo, Freud dall’autore dello Zarathustra. Specie nel dopoguerra, specie nei paesi devastati dal totalitarismo. Gli storici della filosofia hanno ormai battuto tutti i cunicoli, ora segreti ora evidentissimi, che connettono l’uno all’altro ambiente, se non l’uno all’altro autore. Per parte sua Napolitani ha capito, a un certo punto, e ha argomentato con forza, con la sua pratica e con il suo insegnamento, che non si può pensare e non si può fare psicoanalisi senza confrontarsi con Nietzsche, e in particolare col Nietzsche della Genealogia della morale. Di nuovo, se l’urgenza del momento dovesse suggerire un motto, si potrebbe azzardare che la psicoanalisi ha sempre a che fare col trattamento di un debito. Con l’illuminazione di un passato che grava come insoluto e che ci mette nella posizione degli insolventi. O, ancora, con la rievocazione di un antenato al quale si avverte di dovere qualcosa e dal quale si avverte di doversi congedare. Con il tentativo di spezzare le tavolette in cui il debito sembrava scritto per sempre, come avveniva dalle parti dei Sumeri. I cui re, non a caso, si insediavano spezzando le tavolette e inaugurando il tempo nuovo, azzerando il credito degli uni sugli altri, cancellando la fede che quel credito e quel credere presupponeva, mettendo tra parentesi per quanto possibile le credenze che quel credito portava con sé. Che cosa rappresenta Nietzsche, in questo senso, se non un’opzione molto precisa circa il trattamento possibile del debito e della colpa, se non un modo molto profondo e difficile di rielaborare, di imparare passo dopo passo ad avere a che fare col debito e con la colpa, con questo identico e duplice Schuldigsein? È curioso, detto per inciso, che l’uomo che ha visto così a fondo il nesso possibile tra Nietzsche e la psicoanalisi, tra la via nietzscheana al pensiero del debito e la via psicoanalitica al trattamento della colpa e del dover-essere, fosse l’uomo che Bernhard con una mano di tarocchi aveva fotografato come senza padre, o destinato a non averne, a non poterne avere, a non volerne avere. La Genealogia della morale è in questo senso anche una genealogia dell’“uomo psicoanalitico”: quell’uomo che Peter Sloterdijk ha descritto come un essere umiliato, immiserito dall’analista che lo infantilizza e colpevolizza, un uomo ipercristiano che scopre il proprio debito con l’altro e che santifica ogni giorno la mancanza che ne deriva, un pavido che fa del proprio divenire altro da quell’altro il peccato capitale, la negazione del prestigio della legge, l’insulto al passato come lapide del dover-essere. Sarà possibile un giorno una psicoanalisi nietzscheana? Una psicoanalisi che non sia come l’economia una scienza triste, o che non sia essa stessa una economia tristissima ma una scienza gaia e magari una gaia scienza economica? Sarà possibile una simile psicoanalisi senza rigettare lo stesso Heidegger, non necessariamente un buon viatico a Nietzsche e al suo “al di là” della morale? L’opzione fenomenologica che Napolitani da ultimo ha abbracciato tende dal lato di Heidegger e del suo perenne kierkegaardismo, oppure dal lato di una Genealogia della morale che proprio in quanto esercizio genealogico svolto sul nostro mos è emancipazione da un mos che si dà infine a vedere come non nostro, come altro da noi, come qualcosa che noi non possediamo ma ci possiede? L’ultima mail che Napolitani mi ha scritto, dopo la fine di un’analisi che per un certo tratto ha coinciso col finire dell’analista e col mio ragionare sovrastato dal commento misterioso di quella tosse acquosa e dilagante, era una citazione dall’amatissimo Dizionario di Niccolò Tommaseo. La si trova alla voce “Nostro”. Recita: “Stimando nostro quanto ci è alieno, e il nostro negligentando come alieno, sarà la nostra vita una perpetua confusione.” Ultima mail che solleva un’ultima domanda. La formulerei come segue. Si può pensare “il nostro” come vuoto, oppure come divenire puro (direbbe Deleuze), oppure come tendenzialmente improprio (direbbe Derrida)? Lo si può pensare così, proprio in quanto tendenzialmente, sperabilmente, finalmente disalienato? Qui, in ogni caso, mi sembra si annodino tanti cammini di Napolitani, cammini solo apparentemente convergenti, in realtà sfaccettati, contrastanti, dissonanti. Qui, forse, sta il nodo che si deve snodare, se si vuole far qualcosa di questa eredità ricchissima e sfuggente, spigolosa e generosa come chi ne ha tracciato le linee, abbandonandole e riprendendole senza sosta per una vita intera.
Mariuccia Cagna (settembre 2013) DIEGO Il dolore al momento è sasso levigato pesantemente tondo liscio senza appigli. Nel concavo delle nostre mani si fa più lieve di palmo in palmo.
Tiziana Schiavi (gennaio 2014) Ciao Diego. E’ passato molto tempo prima che potessi ritrovare le parole per dirti …. Ricordo quando ci incontrammo io 28 enne e tu già sui 60 ma sembravi così giovane e pieno di vita, mi sorprese il tuo sguardo sereno e scanzonato, divertito e riflessivo, luminoso e attento testimonianza di una gioia di vivere e di vita . Pensai di potermi dissetare alla tua fonte prima di scoprire che una era anche in me e che tu mi mostravi ogni volta che si presentava e con dispiacere mi accorgevo del mio lavoro instancabile per cementarla. Ma anche il tuo era un lavoro instancabile, benché ci provassi, trovavi sempre la fonte di cui sapevi apprezzare anche quell’unica goccia di acqua. Abbracciavi la vita in tutte le sue manifestazioni le più misere e desolanti le più appassionanti e pericolose senza indietreggiare. Mi hai mostrato che si poteva e che valeva la pena vivere amando le debolezze e le fragilità i tormenti e le storture mescolandosi nel traffico delle emozioni e dei sentimenti con fiducia senza perdere quello sguardo attento e delicato sul mondo pur navigando a vista. Ancora nel giorno del tuo ultimo compleanno, già provato e sofferente, hai sorriso divertito indossando il panama che dei bimbi ti hanno regalato e hai giocato con loro. Ecco questo e’ l’amore per la vita che ho visto in te, l’accogliere ogni gesto, prestargli attenzione, coinvolgersi con l’anima che sorride e iniziare un dialogo amoroso.
Antonio Maria Ferro (9 luglio 2014) L’ invito di Paolo Tucci a ricordare Diego Napolitani, in vista del numero della rivista che la nostra Società gli dedicherà, mi ha portato a rileggere in questi due mesi molti suoi lavori, con interesse rinnovato, curiosità affettuosa, molta gratitudine e, per quanto attiene il pensiero di Diego degli ultimi anni, talvolta con qualche perplessità. Ho conosciuto Diego Napolitani ai Seminari di Psicoanalisi e Filosofia di Torre Pellice del 1981/1982 in uno di quei “laboratori che contribuirono alla decostruzione dei fondamenti sicuri sia della psichiatria che della psicoanalisi”. (Napolitani 2011). In realtà avevo già letto gli atti del Seminario di Psichiatria di comunità e Socioterapia, che egli aveva organizzato a Milano nel1970, editi allora dalla rivista Minerva Psichiatrica e Psicologica. Vi parteciparono veramente persone fantastiche e tra i tanti ricordo P.C. Racamier e S. Resnik che, con Diego, mi sono stati maestri nella professione e nella vita, maestri con i quali ho avuto la fortuna di lavorare . Io venivo dall’esperienza “colta” e innovativa di psichiatria di comunità intrapresa a Reggio Emilia da Giovanni Jervis negli anni ‘70: l’incontro con Napolitani fu allora determinante per l’evoluzione critica del mio modo di pensare e di operare. In realtà la mia prima cura personale, quella di gruppo con Diego, una lunga esperienza di supervisione con lui anni dopo – e quella altrettanto importante con Luciano Cofano – segnarono il mio interesse primario per il lavoro con e nei gruppi, sia come psichiatra che come analista. Queste esperienze mi portarono poi ad aderire alla Sgai negli anni ‘90. La percezione gruppoanalitica e Diego Napolitani hanno quindi fortemente colorato non solo il mio modo di operare ma anche di stare al mondo . Egli fu un vero “temerario” che esplorò, ed insegnò ad esplorare, territori di frontiera che ben pochi psicoanalisti e psichiatri esploravano in quegli anni ed ahimè anche ora. La psicoanalisi accademica italiana – al contrario di quanto, seppure in forme minoritarie, avveniva in Inghilterra ed in Francia, ma anche negli USA – poco contribuiva allo sviluppo di modelli “pensati” nella cura dei pazienti gravi e nella cura necessaria delle istituzioni e dei gruppi di cura (poi chiamati équipes). Ricordo tra i pochi in Italia allora, oltre a Napolitani, Massimo Ammaniti a Roma , il gruppo veneto dell’ASVEGRA con Fasolo, Nose, Di Marco, Dalla Porta e Ferlini, e soprattutto il gruppo pavese con De Martis, Petrella e poi Eugenio Torre, Barale, Vender, Bezoari, Caverzasi e Antonino Ferro. Si trattava della terapia istituzionale che proprio in quel seminario del 1970 fu presentata in Italia e che mi portò poi a lavorare con P.C. Racamier al 13°arrondissement a Parigi e a Besancon alla Velotte (Ferro 2013) . Napolitani mi ha poi insegnato a “lavorare per una forma sempre più articolata di comunicazione” (M. Pines 2000) perché il dia-logo, ossia verbo che passa attraverso, ponte che collega due sponde del fiume, non è centrale solo per la cultura gruppoanalitica ma lo è anche per una vita umana libera dagli ideologismi delle verità a priori e autoreferenziali e curiosa e rispettosa per “l’altro da noi”. Venne più volte a Savona per seminari e convegni e partecipò generosamente al mio libro “La Bottega della Psichiatria”( Napolitani 1999). Ricordava allora a me ed ai miei colleghi che “noi siamo degli operatori che abitano i territori di frontiera e dobbiamo essere come quei temerari sulle macchine volanti (il termine era di L. Cancrini) che attraversano diversi saperi”: questa è l’originalità e la bellezza del nostro lavoro perché porta a metterci in rete con tanti “altri da noi”, a dia-logare appunto, ad imparare cose nuove per meglio operare, in modo flessibile, adattabile, rimodellabile rapidamente a seconda dei contesti di cura e di vita. A proposito poi del modo di prendersi cura dei pazienti anche più gravi ricordo che Diego metteva a confronto i concetti di “prevedere con” e di “provvedere a”: “Prevedere con, modifica una capacità di vedere ciò che è davanti a se stessi e in termine di sviluppo temporale dell’evento, all’interno della gestione della propria personale esistenza, mentre provvedere (o la provvidenza) indica pensare di distinguere le cose a favore o al posto di qualcun altro”(1988). Questa sua indicazione ancor oggi mi accompagna, nell’operare sia come psichiatra che come gruppoanalista, ricordandomi sempre il rischio seducente dell’arbitrio provvidenziale. Un altro importante insegnamento mi venne “Dalla cultura dell’errore ad imparare ad errare”(2000) quando scriveva: “condannato ad essere uomo nella sua irriducibile incompiutezza conoscitiva e quindi nella sua inesauribile creatività”, condannato, se voglio mantenermi umano, al dia-logo verso nuove esperienze, ma partendo dalle matrici in cui sono stato, sono e sarò iscritto e che continuamente tenderò a travalicare, non essendone prigioniero: questa, ancor oggi, è la prassi che rende molto piacevole il mio lavoro, a 43 anni dalla mia laurea in medicina a Padova nel 1971. Napolitani e P.C.Racamier, mi hanno poi insegnato a guardare ai luoghi di cura (comunità terapeutiche, centri crisi , servizi per adolescenti e per pazienti affetti da DCA, ambulatoriali e soprattutto residenziali, strutture che ho attivato negli anni in cui a Savona ho diretto il Dipartimento di Salute Mentale) come a delle strutture di frontiera, a “sistemi relazionali” (sono parole di Diego) non solo da organizzare e gestire ma per “imparare a conoscere”, veri setting di cura rapportabili a quelli psicoanalitici, se li sappiamo leggere, valorizzare, …spazi fisici e mentali dove mi è stato possibile sperimentare per anni il contributo della cultura gruppoanalitica nella terapia istituzionale. Così “il divertimento” di cui scrive Diego Napolitani (2000) è stato possibile ed è stato spesso possibile creare con gli operatori ed i pazienti dei buoni oggetti di cura… le nostre terapie riuscite dove “il prendersi cura” era animato dal pensiero di grandi maestri come Resnik, Racamier, Jammet, Ciompi, Pommerau e Diego Napolitani al quale anche per questo penso con affetto e gratitudine. Per rispetto a lui devo dire che, a mio avviso, egli andò via via allontanandosi da questo serrato confronto con la clinica dal dialogo, che deve essere continuo, tra ipotesi teoriche e la pratica che si fa esperienza. Diego scriveva nel lavoro del 2000 sopracitato: “Ex – periri … tento , provo, assaggio … per cui esperienza è ciò che risulta da un tentativo, dal contatto con un non-so-ancora … che apre ad un errare vitale”. I suoi pensieri, ma non poche delle diatribe della nostra Società , così lontane dal mio mo(n)do clinico, non poche volte mi sono apparsi come quei “gruppi marmorei ” che Diego aborriva e che mi aveva insegnato a fiutare, per non restarne pericolosamente affascinato e pietrificato a mia volta. La curiosità si è fatta troppo spesso certezza, Diego è diventato, suo malgrado … ne sono certo suo malgrado e credo dolorosamente, talvolta un “gruppo marmoreo”. Noi siamo clinici e da lì parte ogni nostra analisi: non siamo filosofi, sociologi, etc. anche se attraversati da questi molteplici saperi, come sopra ricordato; perder questa dimensione facilita la perdita della nobile prassi, così come la intendeva Antonio Gramsci ed anche K.Popper, sintesi di teorie utilizzabili ma anche via via modificabili proprio nell’ incontro, nell’esperienza relazionale con i pazienti, singoli e gruppi, e con le istituzioni di cura. Ecco quel particolare “reale”, che per noi sono la clinica ed i nostri pazienti, sembra talvolta scomparire ed allora la relatività delle nostre soggettività, delle nostre gruppalità interne, non più dialoganti con il mondo che è fuori di noi, rischia di divenire – come scrive A.Correale nel commento al lavoro di Diego nel testo “La clinica istituzionale in Italia” (2011) – “una nuova droga, altrettanto sofisticata di quelle già esistenti”. Correale scrive ancora “reale è ciò che sta fuori di noi, l’altro, la natura, il mondo nella sua infinita complessità e segretezza. È importante che la psicoanalisi si apra a questo reale ed utilizzi i suoi potenti strumenti per allargare la nostra sfera di conoscenza sul mondo degli esseri umani nelle sue parti ancora sconosciute”. Il mio “gruppo interno Diego” resta quindi quello dello scienziato temerario e colto, del fine clinico che sostenne non di rado grandi solitudini creative ma si negò la sicurezza di matrici gruppali fisse ed asfittiche. In conclusione mi sembra che ancora oggi la mia “gruppalità Diego” abbia a che fare con la curiosità, la critica scientifica serrata, abbia a che fare con l’empatia, il rispetto ed il divertimento “leggero” nel vivere e nell’operare. Essere insomma come il “cavaliere del secchio” di Kafka, di cui così scrive Calvino(1988): “Uscire alla ricerca d’un po’ di carbone, in una fredda notte del tempo di guerra, si trasforma in quiete di cavaliere errante… al semplice dondolio del secchio vuoto… ma l’idea di questo secchio vuoto che ti solleva al di sopra del livello dove si trova l’aiuto ed anche l’egoismo degli altri, il secchio vuoto sostegno di privazione e desiderio e ricerca… apre la via a riflessioni senza fine”.
* * * * *
Oltre a questi contributi segnaliamo il link della rivista in lingua inglese “EJPsy. European Journal of Psychoanalysis”, che l’amico Sergio Benvenuto, presidente dell’ISAP, ha voluto dedicare alla figura di Diego. http://www.journal-psychoanalysis.eu/diego-napolitani-1927-2013/